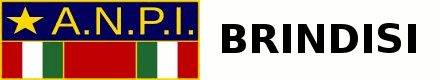L’umiliazione subita nel momento più tragico della nostra storia dall’unità in poi è ancor oggi cosi forte e cocente che è ben difficile parlare dell’8 settembre in termini obiettivi, determinare la verità spogliandosi del cruccio delle passioni. Eppure, è da osservare che l’interpretazione che molti dettero allora degli avvenimenti non regge al vaglio dei dati emersi in questi ultimi anni, che è senz’altro sbagliata l’idea cosi largamente diffusa che il nostro esercito si sia lasciato sopraffare da forze infinitamente inferiori per numero e per mezzi.
In realtà, essendo stata respinta dal governo del 25 luglio la soluzione e la possibilità d’appoggiarsi direttamente al popolo nella resistenza armata e restando valida solo la contrapposizione delle forze regolari messe in campo dall’una e dall’altra parte, non era più possibile ottenere 1’8 settembre la salvaguardia dell’intero territorio nazionale: la parte più ricca del nostro paese, la parte settentrionale, era già da ritenersi in saldo possesso dell’invasore tedesco, superiore di almeno tre volte alle forze residue del nostro esercito.
Ciò non diminuisce, anzi aggrava, la responsabilità del governo del 25 luglio che, dopo aver creato tale situazione dando libero accesso ai tedeschi, aveva almeno il preciso dovere di compiere ogni sforzo per conseguire la vittoria ove il rapporto di forze si conservava a noi favorevole. Per ciò la difesa o la mancata difesa di Roma assume un valore esemplare per rendersi conto dell’8 settembre: qui lo stesso tedesco aveva ritenuto d’esser battuto in partenza, aveva previsto e perfino offerto al governo Badoglio il ripiegamento delle sue truppe verso il Nord. Quale speranza concreta potevano avere due divisioni germaniche (la 3° corazzata di fanteria nella zona di Viterbo e la 2° di paracadutisti ancora in via di costituzione a Pratica di Mare) di contrastare il successo all’intero corpo d’armata motocorazzato italiano che si schierava con quattro divisioni, l’Ariete, la Piave, la Granatieri e la Centauro, a difesa della capitale? Immaginando di vedere le forze contrapposte in Italia disposte come pezzi di una scacchiera in una partita già volta verso il suo finale, sembra appunto dì poter scorgere nell’apparente disordine un’unica idea o un’unica direttiva chiara ed esplicita: l’intenzione di Badoglio di concentrare le sue forze a difesa della posizione più importante abbandonando tutto il resto all’avversario. Il fatto saliente, il fatto più noto della difesa di Roma è, nel ricordo di tutti, la resistenza opposta dai granatieri all’avanzata tedesca lungo la via Ostiense dalla Magliana a Porta san Paolo, resistenza accanita e appoggiata nell’ultima sua fase dal generoso intervento popolare. Ma un primo essenziale punto da mettere in chiaro è il seguente: i combattimenti della via Ostiense ebbero inizio quando già s’era rinunciato sul piano strategico alla difesa della capitale, e non furono, malgrado l’eroismo e le stesse intenzioni di coloro che vi parteciparono, che un episodio di disperata resistenza, senza alcuna possibilità di incidere sulla situazione generale. Questo è, in fondo, il solo punto da tenere presente se si vuol dipanare l’intricato groviglio degli avvenimenti, che s’inizia la sera del 7 settembre con la missione a Roma del generale Maxwell Taylor intesa a predisporre lo sbarco della divisione paracadutisti secondo gli accordi di Cassibile (peraltro non effettuato in seguito alle informazioni raccolte) e si conclude con il tentativo di Badoglio, compiuto all’ultima ora, di far rinviare l’annuncio dell’armistizio (particolare significativo: fra gli argomenti che Badoglio presume di poter utilizzare a tale fine v’è anche «la trasparente preoccupazione di Taylor… per la crescente potenza militare russa»: tanto possono ancora le sciagurate illusioni o le segrete speranze
che hanno caratterizzato le trattative per l’armistizio!). Anche in questo caso la storia non si fa con i «se», ma ponendo attenzione a ciò che effettivamente si verificò e da cui tutto il resto dipese. Si verificò dunque l’avvenimento più assurdo, più lontano da ogni ragionevole previsione: la decisione del Comando supremo di ordinare il ripiegamento del corpo d’armata motocorazzato su Tivoli per proteggere la fuga del re e del suo corteo di generali. E la decisione non dipese dalle circostanze, dall’esito avverso di un qualsiasi combattimento, ma fu presa fra le ore due e le ore quattro del 9 settembre, quando ancora non era accaduto alcun fatto cosi grave da compromettere la situazione. Dopo l’annuncio dell’armistizio nella tarda sera dell’8, la 2° divisione paracadutisti, valutata a non più di 15 000 uomini, s’era mossa verso Roma e dopo aver sopraffatto facilmente i reparti costieri aveva proseguito lungo la via Ostiense venendo a contatto con i caposaldi della divisione granatieri e ottenendo con la sorpresa e l’inganno qualche modesto successo locale. Questo era tutto: fra le 2 e le 4 di notte il resto del nostro schieramento non era stato ancora investito dal nemico, non erano ancora venute a contatto di fuoco col tedesco le due divisioni italiane più forti, l’Ariete Montebello semovente e la Piave. Malgrado ciò, malgrado che nulla autorizzasse ti ritenere compromesse le sorti della battaglia, il Comando supremo emise il divieto di difendere Roma, decise, senza una ragione al mondo sul piano militare, il sacrificio della capitale.
Tutti i combattimenti che poi seguirono e non soltanto quelli dei granatieri che rioccuparono all’alba il terreno perduto, si verificarono dopo e non prima dell’ordine di ripiegamento; e furono combattimenti, anche ciò è importante ricordare, che si svolsero contravvenendo in tutto o in parte agli ordini ricevuti dal Comando supremo, già al limite della guerra regolare vera e propria diretta dall’alto e la guerra condotta localmente per iniziativa dei comandanti dei reparti, in una parola, la guerra partigiana.
Alle ore 5 il generale Tabellini comandante della Piave riceveva telefonicamente l’ordine di ripiegare con l’intera divisione su Tivoli.
Ritenuto l’ordine « talmente assurdo da far ritenere che fosse dovuto a un errore di trasmissione», ne richiedeva conferma al Comando del corpo d’armata. Ma anche quando questa gli arrivò per iscritto, « non dava esecuzione all’ordine ripetutamente ricevuto» e si affrettava invece (ore 8 circa) a disporre perché la Piave assumesse senz’altro «formazioni di movimento valevoli anche per qualsiasi altro impiego della divisione». Poteva cosi affrontare decisamente il reparto di paracadutisti tedeschi che aveva attaccato di sorpresa a Monterotondo difeso da pochi reparti della divisione Re. Il combattimento si protraeva per l’intera giornata nell’abitato e vi partecipava la popolazione civile «con armi di circostanza e con quelle raccolte dai caduti »; finché i tedeschi, dopo aver subito almeno 400 perdite su 1500 uomini, erano costretti ad alzare bandiera bianca sul castello di Monterotondo. Contemporaneamente, anche a Mentana carabinieri e popolazione attaccavano e annientavano i tedeschi che avevano occupato l’abitato. Il generale Tabellini si preparava quindi, nella mattina del 10, ad accorrere in soccorso della divisione Granatieri, allorché lo raggiungeva nuovamente l’ordine di trasferirsi nella zona di Tivoli. Ritenendo di dover partecipare a qualche « manovra » strategica di cui gli sfuggivano le finalità, si decise, a malincuore, ad eseguire finalmente l’ordine, « E la bella divisione Piave – secondo la sua stessa testimonianza – già pronta ad accorrere in aiuto dei Granatieri, si allontanava dalla capitale, abbandonando alla loro sorte gli eroici difensori di Roma, e lungo il cammino udiva ancora i colpi delle loro artiglierie, ripetuti e insistenti come una voce, sempre più lontana, di richiamo».
Alle ore 5,30 il generale Cadorna comandante dell’Ariete riceve anch’egli l’ordine suddetto, impartito questa volta in forma più blanda, con l’avviso che sul momento solo alcuni reparti della divisione dovevano ripiegare per essere poi seguiti dagli altri nel corso della giornata. Il Cadorna esprime il suo sdegno e, pur accettando la volontà del Comando supremo, impegna battaglia col grosso della divisione rimasto sotto il suo comando, prima nel settore di Monterosi
e poi in quello di Bracciano. Il più forte reparto tedesco in Italia centrale, la 3° divisione di fanteria corazzata, viene battuto in entrambi i settori, subendo gravissime perdite: quaranta carri armati, un centinaio d’autocarri, due batterie, mezzo migliaio d’uomini nel primo, trenta carri armati su quaranta impegnati in combattimento nel secondo. Cosi dura è la batosta ricevuta che fino al pomeriggio dell’11, quando a contrastargli il passo non era rimasto che il velo di protezione della divisione Re, il tedesco non osa più muoversi e aspetta la soluzione non dalla forza delle armi, ma dalle trattative che si svolgono intanto a Roma. Infine lo stesso comandante del corpo d’armata motocorazzato, il generale Carboni, scomparso ormai nella fuga verso il Sud ogni Comando superiore, decide per suo conto di riprendere la difesa di Roma: e nella mattina del 10 dà ordine alla Piave e all’Ariete d’accorrere in difesa della capitale. La marcia dei reparti viene arrestata dalle notizie della capitolazione firmata nelle prime ore del pomeriggio da Westphal per conto di Kesselring e da Giaccone per conto non si sa bene di chi, tanto le autorità militari rimaste a Roma si palleggiano fra di loro anche la responsabilità della firma. La capitolazione prevede la consegna delle armi al nemico e la definizione di « Roma città aperta » con comandante Calvi di Bergolo: non c’è bisogno qui di dire come, appena consegnate le armi o meglio disfatti i reparti, l’invasore si guardò bene dal rispettare I’« immunità di Roma », ma l’occupò e spadroneggiò ovunque e comunque gli facesse comodo.
Arrivati a questo punto, dobbiamo constatare che ancor più inspiegabile riesce l’ordine impartito dal Comando supremo la notte dell’8 settembre. Mancava fin dall’inizio una qualsiasi giustificazione sul piano tecnico-militare; gli avvenimenti che abbiamo sommariamente citato dimostrano che nei reparti operanti c’era l’elemento essenziale per conseguire la vittoria, la volontà di combattere contro il tedesco. Dimostrano anche che nella prima fase degli avvenimenti seguenti all’8 settembre, la «quinta colonna fascista» operò ai margini dei reparti operanti, non intaccò lo spirito combattivo di quelli effettivamente impegnati in combattimento, i quali si batterono valorosamente anche dove il comandante era « fascista » (tale è il caso ad esempio della divisione Granatieri agli ordini di quel Solinas che aderì poi alla repubblica di Salò). Fu dunque la decisione del Comando supremo dovuta soltanto, come si è spesso detto, alla « paura fisica» irrazionale e irragionevole, che invase nella notte dell’8 settembre gli uomini del 25 luglio fino al punto di farli dimentichi di ogni residuo di dignità nazionale? La paura ci fu senza dubbio, se è vero, com’è vero, che nel tracciare l’ordine di ripiegamento si sbagliarono anche i punti cardinali e si partì senza lasciare alcun ordine o direttiva alle autorità rimaste a Roma, all’insaputa degli stessi ministri badogliani. Ma la paura, per quanto ossessiva o contagiosa, non basta a spiegar rutto, è anch’essa una « forma » e non la sostanza di quella politica o mentalità di classe che determinò l’abbandono di Roma. Rimane infatti fermo l’indirizzo costante di quella politica, l’intenzione già espressa nel proclama « la guerra continua » di « non voler fare la guerra ai tedeschi », ma di lasciare questo oneroso compito agli alleati angloamericani. Far la guerra ai tedeschi significava accogliere il sentimento popolare di odio verso l’invasore, farsi partecipe di esso, scendendo dal piedistallo del proprio egoismo; dare, in una parola, ragione ai « comunisti ». Perché compromettere con
un tale atto avventato una situazione cosi solida, cosi sicura proprio all’ultimo momento? Non a caso l’iniziativa dell’8 settembre nella sua forma più tipica, la mancata difesa di Roma, passa a Roatta dalle mani del vecchio sovrano e di Badoglio che sembrano seguirlo, almeno in un primo momento, presi fra la paura e il sonno, come riluttanti o incerti. Perché era ben giusto che un tale disprezzo degli interessi nazionali fosse attuato da Roatta, formatosi alla scuola del
fascismo, ben più esperto e spregiudicato della vecchia casta militare in un compito del genere. Eppure, anche sotto l’aspetto della difesa dei propri interessi, degli interessi dinastici e della conservazione sociale, non si può affermare che con l’abbandono di Roma la monarchia dei Savoia abbia fatto un buon affare. Né vale invocare il precedente di sovrani costretti all’esilio sotto l’incalzare dell’offensiva nemica e tornati da quest’esilio, al termine della guerra, senza disonore. Il fatto è che Vittorio Emanuele III abbandona Roma ancor prima d’averne tentata la difesa, senza preoccuparsi in nessun modo di ciò che resta dietro di lui. « La fuga di Pescara » sancisce definitivamente la separazione tra monarchia e popolo, né può essere più cancellata. E lo stesso sovrano, o chi gli è più vicino, non può prevederne le conseguenze, poiché non prevede in nessun modo che quel « popolo », cosi abbandonato al suo tragico destino, possa esprimere una propria volontà autonoma; non può prevedere che lo stesso 8 settembre possa trasformarsi nel principio della rinascita.
Ciò accadde innanzi tutto a Roma. La giornata del 9 mentre la divisione Granatieri era impegnata nella difesa ad oltranza del ponte della Magliana, nella città, abbandonata a se stessa, in mezzo alla ridda delle voci contrastanti, i gruppi politici antifascisti cercavano faticosamente d’orientarsi sulla situazione e di prendere contatto con gli organi del governo Badoglio. Il Comitato delle opposizioni delega a questo scopo nelle prime ore del mattino Bonomi e Ruini, i quali si recano al Viminale e vi apprendono la notizia della fuga del re. Li
ha preceduti una missione dell’Associazione combattenti richiedendo la distribuzione di armi per potersi battere a fianco dell’esercito. La richiesta, benché appoggiata dagli emissari del CLN è « respinta con un no freddo. Anzi qualcuno aggiunge che non bisogna esasperare
gli invasori ».
Posto di fronte alla più drammatica delle situazioni, con la sensazione di avere dinnanzi a sé il vuoto più assoluto d’ogni « autorità costituita» il Comitato delle opposizioni reagisce immediatamente; constatando la frattura decisiva determinata dall’8 settembre e traendo da questa constatazione l’indicazione delle sue nuove responsabilità. Alle ore 14,30 esso approva la seguente mozione:
Nel momento in cui il nazismo tenta restaurate in Roma e in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di liberazione nazionale, per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni .
V’è nella mozione il freddo riflesso della drammaticità dell’ora e sgorgano con forma appassionata quelle affermazioni che costituiscono l’antitesi più precisa, alla politica seguita da Badoglio nei 45 giorni; l’appello rivolto al popolo affinché lotti e resista, la « riconquista » della dignità nazionale attraverso la lotta e non mediante i meschini e illusori calcoli del « rovesciamento delle alleanze ».
In tale senso la mozione è il frutto immediato della politica antifascista dei 45 giorni, il suo « compendio », è stato detto ma anche qualcosa di più. Mutando il proprio nome, assumendo per la prima volta quello che caratterizzerà un’intera fase della vita nazionale, il Comitato delle opposizioni – ora Comitato di liberazione nazionale – muta anche di sostanza; e se conclude la sua esperienza passata, preannuncia anche quella futura di cui sono tuttora indistinti i lineamenti. La «volontà morale», l’impulso etico dell’antifascismo precede anche in questo caso la precisa determinazione della linea politica; e ciò deve essere tenuto presente se si vuole interpretare giustamente questo fondamentale documento storico.
Intanto nella città incerta fra le più contrastanti notizie, fra le voci più assurde, si organizzano i primi gruppi d’armati facendo capo ai partiti di sinistra, ai comunisti Longo e Trombadori, ai socialisti Pertini e Gracceva, agli azionisti Baldazzi e Lussu.
La distribuzione delle armi provoca vari incidenti con la polizia, a stento repressi all’intervento dei dirigenti antifascisti; fra la confusione, il sospetto e lo sbigottimento corre questa vena generosa d’ardimento popolare, come l’unico elemento che abbia un significata positivo, in cui traluca la speranza del domani. I primi gruppi di civili sono ben presto in linea in uno dei punti più delicati del « fronte », mischiati insieme con un reparto di paracadutisti al bivio dell’Ardeatina e dell’Ostiense e nella giornata del 10 si accentua di ora in ora l’intervento popolare sul campo di battaglia. I granatieri hanno ricevuto il rilevante rinforzo del Montebello, l’eroico squadrone che sino all’ultimo condurrà una serie di contrattacchi sacrificando quasi tutti gli ufficiali e tutti i pezzi; altri reparti delle Forze Armate affluiscono sull’Ostiense alla spicciolata. È la prima volta nella storia d’Italia dal ’48 in poi che il popolo interviene spontaneamente a fianco delle Forze Armate, supera d’un balzo il distacco tradizionale. Quando già la resistenza « regolare » va esaurendosi e già è firmata la « resa », allora è il momento che quest’intervento svela tutta la sua importanza non solo militare, ma politica. Dalla piramide di Caio Cestio al Testaccio sono in linea i « civili » armati e cade fra essi, a Porta San Paolo, Raffaele Persichetti, giovane studioso, il primo degli intellettuali sacrificatisi nella Resistenza. E in più punti della città si accendono i combattimenti mossi, più che dalla speranza della vittoria, da uno spirito indomito di odio antinazista: fra via Cavour e via Paolina, in via Marmorata, a piazza dei Cinquecento ove sino a sera si spara contro l’albergo Continentale tenuto dai tedeschi. Sono episodi confusi, di cui è difficile rintracciare volta per
volta l’origine e i risultati; ma certo e che in quella resistenza disperata, dispersi in uno spazio quanto mai vasto, isolati l’uno dall’altro, si mischiano insieme i vari ceti sociali e le generazioni diverse, l’operaio e l’ufficiale, il vecchio e il ragazzo; sono i primi bagliori dell’unità della Resistenza e nella notte buia e angosciosa che segue alla resa della capitale essi tracciano la scia d’un indelebile ricordo. Roma non è caduta senza resistere: è stata evitata dal sacrificio solidale dell’esercito e del popolo la più profonda umiliazione che potesse essere inferta alla capitale.
da: Roberto Battaglia Storia della Resistenza italiana 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945. Torino 1964- l’8 settembre – La difesa di Roma pag 76- 83